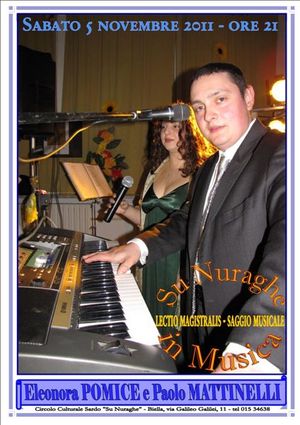Il permanere della forma del triangolo e del rombo, simboli arcaici di morte e rigenerazione – dolci con semi di finocchio selvatico preparati per imbandire la notturna “tavola dei morti”

Con l’approssimarsi del mese di novembre, il tabù della morte viene accantonato e “l’al di là” riappare all’orizzonte del presente. In questi giorni, si intensificano le visite ai cimiteri, si ripuliscono e decorano le tombe dei propri cari defunti. Un richiamo antico porta il disincantato uomo del presente a riavvicinarsi all’universo dei più, invitato a riflettere sulla fragilità della vita e sulla vacuità di tanto correre in mondo eccessivamente accelerato.
Per l’occasione, nel vasto continente europeo – dalle isole britanniche a quelle mediterranee – multiforme appare la produzione di cibi, quali le molteplici varietà delle cosiddette “ossa dei morti o dei santi“, nomi che riuniscono tipologie diverse di pane prodotto in occasione della “Festa dei Morti”, reso festivo attraverso l’edulcorazione con uvetta, sapa, mosto e vin cotto, miele, frutta secca o il più moderno e diffuso zucchero bianco di barbabietola.
Nelle case dei Sardi di “su disterru“, sradicati, costretti lontano dalla terra che accoglie e custodisce gli affetti più cari, permangono forme rituali che attenuano l’infranto dell’abbandono e della partenza. Pertanto, in questo periodo, è possibile osservare il perdurare della produzione di talune specialità alimentari, quali “sas corroncias” e “is papassinos“, il pane e i dolci dei morti, caratteristici dell’Isola. Il primo ottenuto da un disco di pasta acciambellata e “piccada”, sulla quale viene inciso il segno di una “V”; anche is papassinos, con la loro forma a losanga, risultano formati di due “V” accoppiate, con i vertici opposti, ovvero, come due triangoli isosceli con lato minore in comune. Il triangolo (e, ancor più, il suo doppio), è simbolo della divinità femminile, nutrice e sterminatrice, propria della religione degli abitatori dell’Europa che precedettero le grandi invasioni indoeuropee, stimate in due ondate successive, tra il 4.000 e il 3.000 a.C.Continua a leggere →