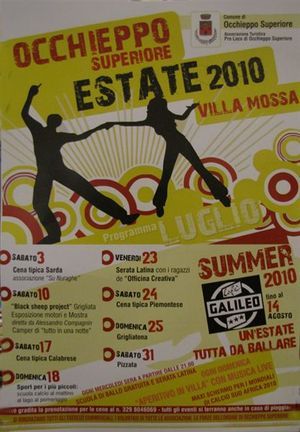Atobiu de maju a Su Nuraghe de Biella, s’urtima borta eus chistionau de is traballus de sa bingia finzas a s’hora de sa binnenna.

Est arribada s’istadi e incumentzat a coi sa primu axina: sa lulliena e fait prexeri andai, a mengianu chitzi, a su sartu po segai unu scarteddu di axina frisca e saboria. Is fundus de axina de papai funti intreveraus cun is atrus. Is innestadoris, candu innestanta po axina de binu custumanta a innestai, de tret’ in tretu fundus de axina grussa de papai: corronniola, calopu, apraxoxa e lulliena, poita coiant prima e abarrant cuaus in mesu a totu sa bingia, arreparaus po is furonis. Po cussu candu cumentzada a essiri agresti si andada a fai sa dennuntzia de sa prutzioni a su barracellau. S’atuario scrieda su catellu e si pagada segundu sa cantidadi de is fundus. Is barricellus cuncordanta sa barraca de su castiu, casi sempri in logu artu in manera chi podessint biri totu in giru, e chi bienta genti intrendi in bingia andanta subitu a controllai si fessit su meri o no. Si ci fiat stetiu dannu, su Major’ de pardu stabiliat sa cantidadi e si no si fiat aciapau s’arresponsabili fiat su Capitanu chi depiat pagai.
Intantis si fiant is traballus de magasinu po essiri prontus a s’ora de binnennai. S’oberiant is potellus de is cuponis, si intrada aintru po dd’us picai de sa tellecuba chi poi si bendiat a is lambicus. Si sciacuanta beni, cun sa palia de linna e sa musa: acua callenti posta a buddiri cun croxu de arangiu allogau e postu a sicai in totu s’ierru. Su strexu piticu: carradas e carradeddas, si limpianta sempri cun sa musa e un’arrogu de cadena, arrumbulendiddas po unu bellu pagu. Totu su strexu, candu si fiat sciutau si mirat beni e si ci fiat netzessidadi si tzerriada su butaiu chi tipiat de folla de istoia is cumessuras obertas po tropu sciutori de is dogas e poi arrecracada is circus. Si torrada a ponni is potellus a is cuponis ungendiddus beni a oll’ ‘e seu chi non mancat mai in magasinu, infrissiu in d’unu cambu de spina ‘e Christu.Continua a leggere →