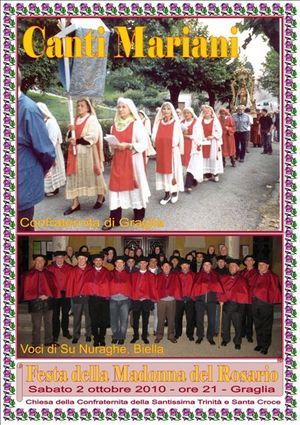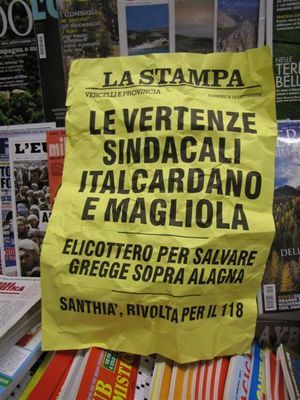Anche l’edizione autunno-inverno 2010 – ottavo ciclo di Su Nuraghe Film – si avvale della collaborazione dell’ISRE, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, che ha messo a disposizione altri due filmati, consentendo di presentare le lezioni di cinema proposte da Sardi di seconda e di terza generazione, Soci, giovani e non, nati fuori dall’Isola.
L’importante Ente, istituito nel 1972 dalla Regione Autonoma della Sardegna, con sede a Nuoro, persegue lo scopo istituzionale di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico; di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni e della storia della Sardegna, attraverso iniziative e manifestazioni culturali da esso ritenute idonee.
In apertura di rassegna verrà proiettato “Viaggio a Lisbona” di Guido Re, opera che documenta la gita sociale 2010 del Circolo Su Nuraghe di Biella nella capitale portoghese.
Nel mese di dicembre verrà presentata “Gent’arrubia” del regista cagliaritano Davide Mocci. L’opera ha ottenuto nel 1994, nel corso del Festival “I Delfini del Tirreno”, il premio speciale per le immagini, grazie alla sua valenza scientifica e culturale. Le informazioni scientifiche presenti in questo documento sono state definite, per alcuni particolari comportamenti dei volatili, come “mai osservate prima” dalla stazione biologica di Tour du Valat in Camargue allora diretta dal dott. Alan Johnson. Sempre nel corso del 1994 il documentario è andato in onda su Raitre all’interno del programma GEO “Viaggio nel pianeta terra” ottenendo il massimo di ascolti di tutta la stagione di GEO 1994. Nel 1995 il filmato ha ottenuto il premio Pellicola d’Argento a “Natura Doc”.
Infine, a gennaio 2011, verrà proiettato “Sonetàula”, di Salvatore Mereu, un film d’altri tempi, magia e asprezze di una Sardegna perduta.Continua a leggere →