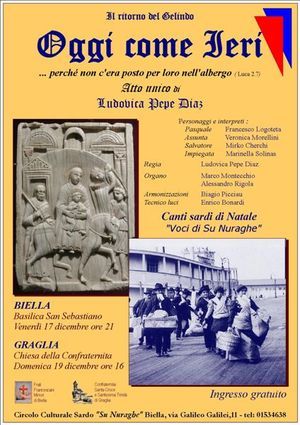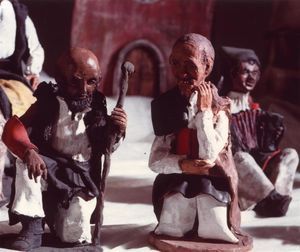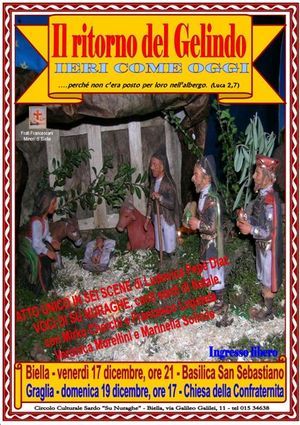Sabato 11 dicembre, alle prime luci dell’alba è mancato Franco Deias di 52 anni.
Nato a Teulada, è giunto a Biella nel 1969 con la famiglia, fratelli e sorelle, il padre Pietro e la mamma Giovanna Aresu. Erano gli anni della grande emigrazione con interi nuclei familiari che si spostavano in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliore.
Da subito, frequenta gli amici della comunità dei Sardi che si andava strutturando; conosce Valeria, la ragazza di Ales che diverrà sua moglie, dalla quale nascerà Luca, l’unico loro figlio. Anche le tre sorelle sposeranno altrettanti conterranei: i fratelli Corrias di Pralungo, Comune nel quale risiedono dal primo momento. Troverà lavoro nel paese vicino come operaio alla Filatura di Tollegno.
Socio del Circolo Su Nuraghe, figura solare dal carattere gioviale, partecipava alle attività sportive gareggiando in coppia fissa con il figlio.
Sul corpo di Franco, composto nella sua abitazione di Camburzano, è stata posta la medaglia dell’ultimo torneo di calcetto di cui è stato vincitore; tra le mani unite, un fiore e il filo del Rosario.
Questa sera, alle 18.30, verrà recitato il Santo Rosario nella Chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace in Pralungo. Domani, 13 dicembre, alle ore 10.30, i funerali sempre a Pralungo. In contemporanea, anche le campane di Teulada batteranno i rintocchi ad annunciare la perdita di un figlio di Sardegna che non tornerà più alla sua cara Isola, mentre le Voci di Su Nuraghe l’accompagneranno con le note del Deus ti salvet Maria.Continua a leggere →