
Negli ampi spazi interni della Casa comunale – alla presenza del comandante Compartimento militare marittimo di La Maddalena, capitano di vascello, Leonardo Deri e del comandante la Scuola sottufficiali della Marina militare, capitano di vascello Roberto Fazio – il sindaco di La Maddalena, Luca Montella ha inaugurato la mostra storico documentaria “Gli emigrati italiani e la Grande Guerra, la Legione garibaldina nelle Argonne 1914-1915”, 7° tappa (5° in Sardegna), rassegna inaugurata a Biella nel 2015, accreditata quale progetto rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Prefettura di Biella, Ufficio Territoriale del Governo, dalla Città di Biella, dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Cagliari e dalla F.A.S.I., la Federazione Associazioni Sarde in Italia, in collaborazione con il Comitato sardo Grande Guerra.Continua a leggere →


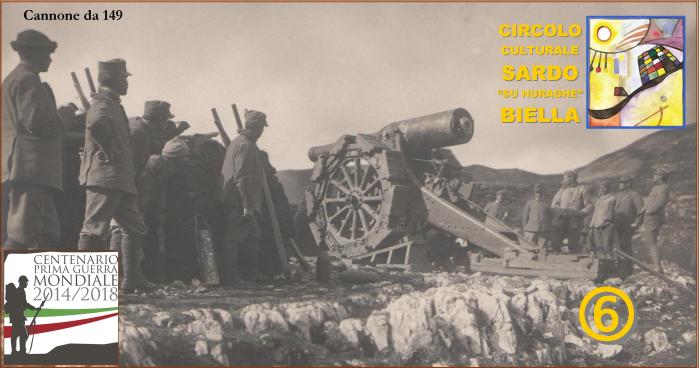
 LÀMPADAS. Mutatis mutandis, lo stesso rigore dobbiamo applicare in Sardegna nel considerare Làmpadas, il nome del ‘(mese di) Giugno’. M.L. Wagner ricorda che già nel Medioevo lampadas era il nome del mese di giugno (St. Sass. II, 17 (60r); 126 (41v). E sostiene che «questa denominazione esisteva nell’Africa settentrionale, dove si celebravano feste con illuminazioni prima in onore di Cerere, poi in onore di San Giovanni, e che queste feste ricorrevano nel mese di giugno, detto perciò lampades come risulta da passi delle opere di Fulgenzio, vescovo di Ruspe, e di S.Crisostomo. Si deve arguire che gli Ebrei espulsi dall’Africa e stabilitisi in Sardegna siano stati i mediatori». Fin qui Wagner.
LÀMPADAS. Mutatis mutandis, lo stesso rigore dobbiamo applicare in Sardegna nel considerare Làmpadas, il nome del ‘(mese di) Giugno’. M.L. Wagner ricorda che già nel Medioevo lampadas era il nome del mese di giugno (St. Sass. II, 17 (60r); 126 (41v). E sostiene che «questa denominazione esisteva nell’Africa settentrionale, dove si celebravano feste con illuminazioni prima in onore di Cerere, poi in onore di San Giovanni, e che queste feste ricorrevano nel mese di giugno, detto perciò lampades come risulta da passi delle opere di Fulgenzio, vescovo di Ruspe, e di S.Crisostomo. Si deve arguire che gli Ebrei espulsi dall’Africa e stabilitisi in Sardegna siano stati i mediatori». Fin qui Wagner.
