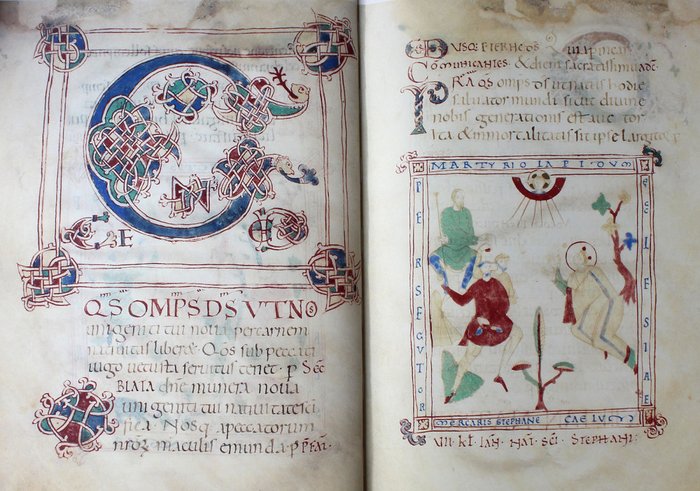
Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi”.
Per proporre alcune parole esemplari della lingua piemontese questa volta abbiamo scelto un brano tratto da uno dei più valenti prosatori del momento, Michele Bonavero, direttore e redattore della rivista “Piemontèis Ancheuj”, a lungo attivo nel campo degli studi linguistici e letterari e valente coadiutore del grande maestro Camillo Brero.
Ecco il brano scelto:
La ca a l’era mìsera, mesa ’d bòsch e mesa ’d pera, con ël cuèrt fàit con fassin-e ’d lësca, mëssonà arlongh a le tampe e ai rantan. Ël fum dël fornel, sèmper anvisch, a surtìa da le filure dle muraje o dij bion strompà grossé con l’assul. Crònio a l’avìa arditala da ij sò cé e, coma j’àutre, spatarà su në spron riaussà ai pé dla montagna, a goernava la pian-a ùmida ch’a së slargava a la fin ëd la comba profonda = la casa era misera, per metà di legno e per metà in pietra, con il tetto fatto con fascine d’erba palustre, falciata lungo gli stagni e le paludi. Il fumo del camino, sempre acceso, usciva dalle fessure dei muri e dei tronchi tagliati grossolanamente con la scure. Cronio l’aveva ereditata dai suoi antenati e, come le altre, sparse su uno sperone rialzato ai piedi della montagna, sorvegliava la pianura umida che si allargava al termine della valle profonda.Continua a leggere →


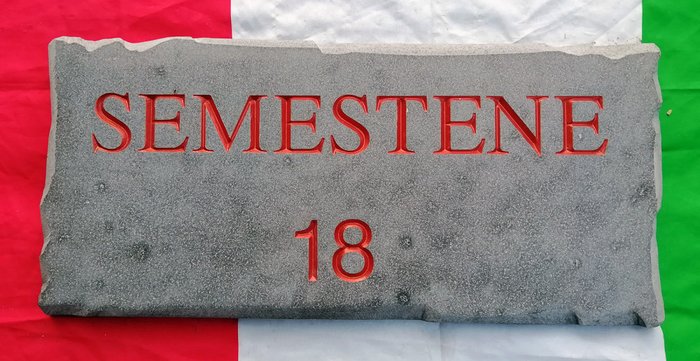
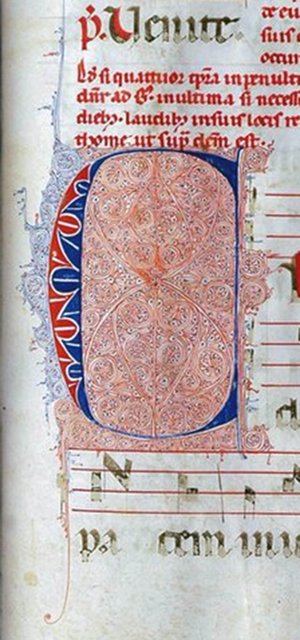 Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella
Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella
